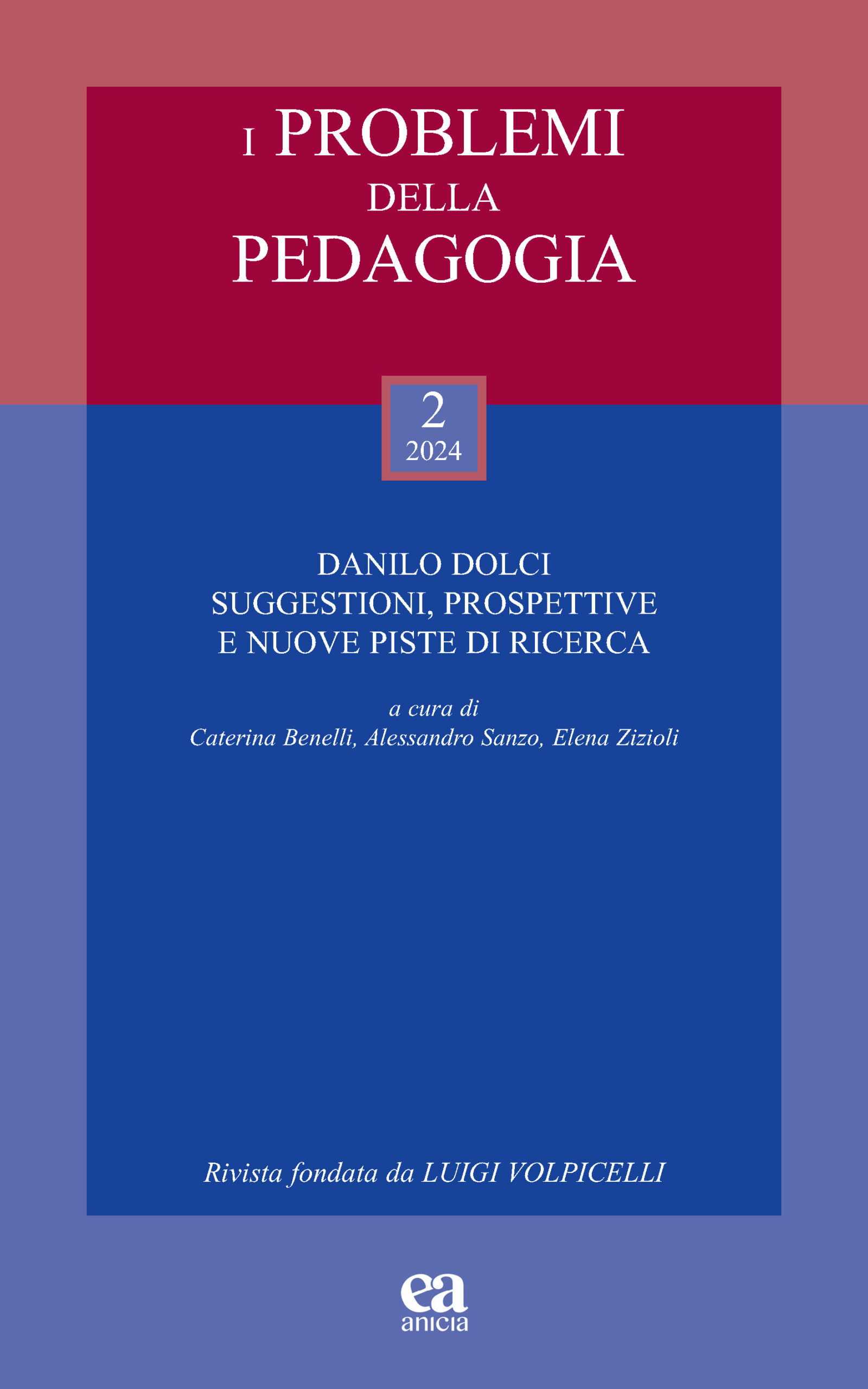
I Problemi della Pedagogia
Secondo Semestre 2024
Sommario
Francesca Borruso
Appartiene al patrimonio del MuSEd (Museo della Scuola e dell’Educazione Mauro Laeng, Università degli Studi Roma Tre) il fondo Vincenzo Borruso, contenente la documentazione relativa alla nascita del Centro di Educazione Sanitaria e Alimentare della Popolazione, sorto a Partinico (Palermo) negli anni Sessanta, con lo scopo di occuparsi della cura e assistenza sanitaria gratuita di quella parte della popolazione che versava in condizioni di drammatica povertà. Un progetto che si inseriva nel più vasto impegno socio-culturale e politico del centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione, coordinato dal noto attivista della non violenza Danilo Dolci, che aveva inizialmente affidato proprio a Vincenzo Borruso la responsabilità del settore sanitario. La storia di questo Centro è emblematica di un momento storico significativo per la Sicilia: quello in cui uomini e donne di diversa provenienza intellettuale e sociale, hanno cooperato attivamente insieme a Danilo Dolci, all’interno di un vasto progetto educativo e politico per il riscatto sociale dei più deboli e marginali, animati da una forte tensione etica, progettuale e trasformativa dell’esistente.
The Vincenzo Borruso Archive was recently acquired within the museum heritage of MuSEd (Roma Tre University), containing the documentation relating to the birth of the Health and Food Education Center for the Population created in Partinico (Palermo) in the 1960s, with the aim of providing free health care and assistance to that part of the population that was in conditions of great poverty. The project was part of the broader socio-cultural and political commitment of the Study and Initiatives Center for Full Employment, coordinated by the well-known non-violence activist Danilo Dolci, who had initially entrusted Vincenzo Borruso with responsibility for the health sector. The history of this Center is emblematic of a significant historical moment for Sicily: the one in which men and women of different intellectual and social backgrounds actively cooperated together with Danilo Dolci, within a vast educational and political project for the social redemption of the weakest and most marginalized, animated by a strong ethical, planning and transformative tension of the existing.
Daniel Buraschi
Danilo Dolci, riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento della lotta nonviolenta, ha lasciato un’eredità significativa per la pedagogia sociale. Questo articolo analizza quattro contributi chiave di Dolci a questa disciplina, in particolare nell’intervento comunitario: lo sviluppo comunitario nonviolento, la pianificazione dal basso, la maieutica reciproca e i laboratori dialogici. L’esperienza di Dolci si distingue per la sua capacità di trasformare realtà oppressive attraverso mezzi pacifici, promuovendo la coesione sociale e resistendo a strutture di dominio come la mafia. Il suo accento sulla pianificazione partecipativa dal basso valorizza le conoscenze e le risorse locali, offrendo un’alternativa sostenibile e di empowerment rispetto a modelli imposti esternamente. La maieutica reciproca promuove il dialogo e la riflessione collettiva come strumenti per l’empowerment comunitario, aiutando i più emarginati a riconoscersi come agenti di cambiamento. Infine, i laboratori dialogici sviluppati da Dolci, concepiti come spazi orizzontali di incontro, facilitano l’analisi critica e la costruzione collaborativa di soluzioni ai problemi comunitari.
Danilo Dolci, recognized as one of the main figures in the nonviolent movement, left a significant legacy for social pedagogy. This article examines four key contributions of Dolci to this discipline, particularly in community intervention: nonviolent community development, bottom-up planning, reciprocal maieutics, and dialogical laboratories. Dolci’s experience stands out for its ability to transform oppressive realities through peaceful means, fostering social cohesion and resisting structures of domination such as the mafia. His emphasis on participatory bottom-up planning highlights the value of local knowledge and resources, offering a sustainable and empowering alternative to externally imposed models. Reciprocal maieutics promotes dialogue and collective reflection as tools for community empowerment, helping the most marginalized to see themselves as agents of change. Finally, the dialogical laboratories developed by Dolci, designed as horizontal spaces for interaction, facilitate critical analysis and collaborative construction of solutions to community problems.
Carlo Cappa
Il breve contributo ripercorre gli sviluppi normativi della nuova formazione iniziale degli insegnanti, analizzandone alcune criticità. In particolare, sono poste in evidenza la mancanza di un trasparente monitoraggio nazionale, la difficoltà di valutare le competenze apprese dai corsisti e i criteri di selezione per l’accesso ai diversi percorsi. Il quadro che emerge ritrae una riforma sorda alle raccomandazioni degli esperti e indifferente alla promozione della qualità e del merito per la formazione dei futuri insegnanti.
This short article retraces the normative developments of the new initial teacher training, analysing some of its critical points. In particular, it highlights the lack of a transparent national monitoring system, the difficulty of evaluating the skills learned by the students, and the selection criteria for access to the different pathways. The overall picture suggests a reform process that has ignored expert recommendations and failed to prioritize quality and merit in the training of future teachers.
Silvia Cerasaro, Francesca Tovena
Il DPCM del 4-08-2023 prevede l’attivazione di percorsi abilitanti da 30 CFU, svolti in base all’art. 13, rivolti a insegnanti interessati già in possesso della specializzazione sul sostegno o dell’abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione. Il percorso viene svolto interamente a distanza. Viene raccontata l’esperienza di una corsista, con ampia esperienza lavorativa su più ordini scolastici. Malgrado alcune criticità, il percorso le ha permesso di vivere un periodo di crescita professionale e umana, apprendendo nuovi contenuti disciplinari e tecnologie per l’insegnamento, confrontandosi con docenti e colleghi sulle scelte didattiche, sperimentando anche a distanza la possibilità di realizzare attività in modalità laboratoriale.
The Prime Ministerial Decree of 4-08-2023 provides for the activation of 30 CFU qualifying courses, under Article 13. These courses take place at a distance and are aimed at teachers who already have a specialisation in teaching support for pupils with disabilities or a qualification in another subject or other educational grade. The experience of a trainee, with extensive previous work experience on several school orders, is reported. In spite of some critical aspects, the course enabled her to experience a period of professional and human growth, learning new disciplinary contents and teaching technologies, exchanging views with teachers and colleagues on teaching choices, and experimenting the possibility of realising activities in laboratory mode also at a distance.
Cristiano Corsini
L’articolo presenta un’analisi dell’adeguatezza della nuova formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola secondaria. In particolare, il contributo evidenzia come la riduzione della durata dei percorsi (nell’arco di un quindicennio si è passati da due anni a pochi mesi) rischi di compromettere lo sviluppo di competenze metodologiche, didattiche e valutative. Una simile compressione temporale sembra essere percepita come problematica dagli stessi corsisti, in buona già impegnati nelle scuole, e rappresenta un’occasione persa in vista della creazione di un nesso significativo tra teoria e pratica, tra insegnamento universitario e attività svolte in aula. L’articolo, oltre a sottolineare la necessità di percorsi formativi più lunghi e flessibili per sviluppare competenze realmente significative, evidenzia la necessità di monitorare e valutare l’efficacia delle scelte effettuate sulla formazione docenti.
The paper analyses the adequacy of the new initial training courses for secondary school teachers. In detail, the article highlights how the shorter time span of the course (in the space of fifteen years it has gone from two years to a few months) may compromise the development of methodological, instructional and assessment competencies. Such a compression of time seems to be perceived as problematic by the course participants themselves, many of whom are already working in schools, and represents a missed opportunity in terms of creating a meaningful link between theory and practice, and between university teaching and classroom activities. The paper, in besides emphasising the need for longer and more flexible training courses to develop truly significant skills, highlights the need to monitor and evaluate the effectiveness of the choices made regarding teacher training.
Giorgio Crescenza
L’articolo esplora l’approccio educativo di Danilo Dolci, centrato sull’uso della parola come mezzo di emancipazione individuale e sociale. Dolci propone una comunicazione formativa che supera la trasmissione passiva delle nozioni e si focalizza su una pedagogia dialogica e maieutica; ci si sofferma, pertanto, su come la domanda diventi il fulcro del processo educativo, favorendo lo sviluppo di un senso di appartenenza e responsabilità civica negli studenti. Attraverso esempi di progetti concreti, come i Centri Educativi di Mirto, Trappeto e Partinico, si esamina l’importanza di un’educazione che unisca conoscenza, emozione e senso civico. Si propone infine una riflessione sull’attualità del modello dolciano per promuovere una società più giusta e coesa, dove la parola è strumento di riconoscimento e di inclusione.
The paper explores Danilo Dolci’s educational approach, centred on the use of words as a means of individual and social emancipation. Dolci proposes a formative communication that goes beyond the passive transmission of notions and focuses on a dialogic and maieutic pedagogy; therefore, there is a reflection on how questions become the core of the educational process, favouring the development of a sense of belonging and civic responsibility in students. The importance of an education that combines knowledge, emotion and civic sense is examined through examples of concrete projects, such as the Mirto, Trappeto and Partinico Education Centres. Finally, a reflection is proposed on the topicality of Dolci’s model to promote a more just and cohesive society, where words are an instrument of recognition and inclusion.
Antonia Cunti
Nell’ambito dell’educazione degli adulti, uno spazio significativo viene riservato all’analisi di figure di pedagogisti ritenute esemplari, laddove l’interesse per questi possa essere ravvisato nella dimostrazione di come sia possibile tradurre il pensiero in forme di azione sociale e politica che esprimano una forte intenzionalità educativa. Per quanto concerne in particolare gli educatori di adulti, è forse da rilevare l’impossibilità di prescindere da una consapevolezza della qualità politica del proprio operare; se, infatti, all’agire sociale degli individui attribuiamo una valenza politica, nel senso della prefigurazione di assetti societari, di sistemi di significato e valoriali, l’educazione degli adulti, nel suo proposito di accompagnare e sostenere le vite adulte, necessariamente esprime un orientamento politico. In Danilo Dolci, la qualità politica della relazione educativa viene considerata ed agita come spazio di promozione della capacità del soggetto di operare per il proprio e l’altrui bene. L’intervista realizzata nel 1993 aggiunge un ulteriore elemento di riflessione sulla qualità politica della relazione educativa, nel senso della promozione del desiderio di realizzazione della propria umanità che ci sostiene nel nostro percorso esistenziale, e può offrire la possibilità di accostarsi ad un’esperienza di ricerca e di intervento nel sociale che dimostra ancora una volta come l’azione educativa sia un’azione per sua natura eminentemente politica.
In the field of adult education, significant attention is given to the analysis of figures of pedagogues considered exemplary, where the interest in these figures can be found in demonstrating how it is possible to translate thought into forms of social and political action that express a strong educational intentionality. Regarding adult educators in particular, it may be noteworthy that it is impossible to disregard an awareness of the political quality of their work; indeed, if we attribute a political value to the social actions of individuals, in the sense of envisioning societal structures, systems of meaning and values, adult education, in its purpose of accompanying and supporting adult lives, necessarily expresses a political orientation. In Danilo Dolci, the political quality of the educational relationship is considered and enacted as a space for promoting the individual’s capacity to act for their own and others’ good. The interview conducted in 1993 adds a further element of reflection on the political quality of the educational relationship, in terms of fostering the desire for the realization of our own humanity, which sustains us in our existential journey. It offers an opportunity to engage with an experience of research and social intervention that once again demonstrates how educational action is inherently political in nature.
Gabriella D’Aprile, Davide Bocchieri, Massimo Occhipinti
L’articolo analizza il ruolo cruciale dell’ascolto attivo nella pedagogia di Danilo Dolci, presentandolo come fondamento di una pratica educativa volta all’emancipazione e alla cittadinanza partecipativa. L’ascolto, ben oltre una semplice ricezione passiva, si configura come un processo relazionale che riconosce l’unicità dell’altro, dando voce alle soggettività emarginate e silenziate. Attraverso un percorso basato sull’autoanalisi popolare, che conduce all’elaborazione del metodo della maieutica reciproca, l’ascolto si rivela, così, uno strumento essenziale per favorire la consapevolezza critica e per innescare processi di trasformazione sociale. L’articolo ripercorre la genesi e l’evoluzione del metodo dolciano, evidenziando come le sue pratiche favoriscano la creazione di spazi dialogici di parola collettiva, in cui ogni partecipante contribuisce alla co-costruzione di significati condivisi. Al centro della riflessione emerge l’idea che l’ascolto rappresenti non solo un elemento fondamentale del processo educativo, ma anche un atto politico di resistenza alle logiche di esclusione e disuguaglianza, trasformando la ‘presa di parola’ in un diritto universale e in un catalizzatore di cambiamento sociale.
The article explores the central value of active listening in Danilo Dolci’s pedagogy, presenting it as the foundation of an emancipatory practice for education and citizenship. In this sense, listening is not considered merely passive: it also involves a relational act that allows the recognition of the other and his or her uniqueness, giving voice to those who are often marginalized and silenced. Through a social and political path from the so-called ‘popular self-analysis’ to the elaboration of the ‘RMA method’, listening becomes a tool for building critical awareness and activating processes of social change. The article, therefore, introduces the history of Dolci’s method and highlights how the practices implemented enable the creation of collective speaking spaces, where everyone can contribute to the co-construction of shared meanings. The main idea is that this active way of listening is a political act of resistance against the logic of exclusion and inequality because the ‘prise de parole’ is deemed a right and a vehicle for social transformation.
Marco Antonio D'Arcangeli
Nel centenario della Riforma della scuola legata al nome di Giovanni Gentile, l’imponente e complessa opera legislativa realizzata dal filosofo siciliano nei venti mesi (31 ottobre 1922-1° luglio 1924) in cui fu Ministro della Pubblica Istruzione nel primo governo Mussolini acquisisce nuovo interesse critico. Il presente contributo, rifacendosi agli interpreti più accreditati, ne analizza i contenuti e il significato in relazione alle idee filosofiche e politiche di Gentile e ai suoi rapporti con il fascismo (movimento e regime) e ne valuta le implicazioni per il sistema educativo del nostro Paese, anche nei primi decenni dell’Italia repubblicana.
In the centenary of the Reformation of the school linked to the name of Giovanni Gentile, the imposing and complex legislative work carried out by the Sicilian philosopher in the twenty months (October 31, 1922-July 1, 1924) in which he was Minister of Education in the first government Mussolini acquires new critical interest. This contribution, referring to the most accredited interpreters, analyzes the content and meaning of the Reform in relation to the philosophical and political ideas of Gentile and his relations with fascism (movement and regime) and assesses the implications for the educational system of our country, even in the first decades of republican Italy.
Emanuele Natale di Nuzzo
Nel 2019 presso il Centro Studi e Iniziative di Palermo Amico Dolci, figlio di Danilo Dolci, si rende disponibile ad un’intervista. La conversazione con Amico oltre a delineare meglio i contorni della figura del padre, soprattutto restituisce l’intimo spaccato di un bambino, un figlio, che ha vissuto in prima linea, è il caso di dirlo, gli scenari delle paterne lotte nonviolente. Il presente contributo ha voluto mettere in luce quelli che sono stati gli esempi rappresentati da Danilo Dolci padre ed educatore per Amico, soffermandosi su cosa è rimasto di quella pesante ‘eredità dolciana’ e su chi ha saputo coglierla, ovvero le ‘persone che godevano della massima fiducia’ agli occhi del Ghandi italiano.
In 2019 at the Centre for Studies and Initiatives in Palermo, Amico Dolci, Danilo Dolci’s son, makes himself available for an interview. The conversation with Amico, in besides better delineating the outlines of the figure of his father, above all gives the intimate insight of a child, a son, who lived in the front line, it is the case to say, the scenarios of his father’s nonviolent struggles. This contribution aimed at highlighting the examples represented by Danilo Dolci father and educator for Amico, focusing on what remained of that heavy ‘Dolci heritage’ and on those who were able to embrace it, namely the ‘people who enjoyed the utmost trust’ in the eyes of the Italian Ghandi.
Francesca Gabrielli, Tiziana Iannone
La povertà educativa sollecita una riflessione di carattere pedagogico, richiamando questioni profondamente radicate nel mondo dell’educazione. In particolare, essa rimanda a diversi approcci pedagogici fortemente orientati verso una prospettiva emancipativa, che hanno contribuito significativamente al suo sviluppo. Le pedagogie emancipative, infatti, ci offrono una lente di lettura privilegiata per comprendere la povertà educativa: riflettendo sugli effetti delle disuguaglianze educative, educatori e pedagogisti del passato, impegnati nella lotta per il riscatto sociale, hanno evidenziato come la mancanza di un’educazione adeguata possa limitare la piena fioritura personale. Tra coloro che hanno affrontato, seppur con termini diversi, quella che oggi definiremmo povertà educativa, spicca la figura di Danilo Dolci. Come altri, egli si è impegnato profondamente nel contrasto alle disuguaglianze educative e nella promozione di strategie di discriminazione positiva, guidato da una visione di equità e giustizia sociale. Attraverso una ricostruzione del suo profilo biografico e un’analisi dell’attualità del pensiero di Dolci nel contrasto alla povertà educativa, il suo lascito viene reinterpretato e riattualizzato, per estrapolarne gli insegnamenti ancora oggi attuali. Il modello educativo proposto da Dolci rappresenta un’eredità preziosa, in grado di affrontare le sfide poste dalla povertà educativa con una visione che rende il cambiamento non solo possibile, ma indispensabile. La sua prospettiva promuove una trasformazione profonda della realtà, oggi più che mai necessaria.
Educational poverty urges a pedagogical reflection, recalling issues deeply rooted in the world of education. In particular, it points to various pedagogical approaches strongly oriented toward an emancipatory perspective, which have contributed significantly to its development. Indeed, emancipatory pedagogies provide us with a privileged lens for understanding educational poverty: reflecting on the effects of educational inequalities, educators and pedagogues of the past, engaged in the struggle for social redemption, have pointed out how the lack of adequate education can limit full personal flourishing. Among those who addressed, albeit in different terms, what today we would call educational poverty, the figure of Danilo Dolci stands out. Like others, he was deeply committed to countering educational inequality and promoting positive discrimination strategies, guided by a vision of equity and social justice. Through a reconstruction of his biographical profile and an analysis of the topicality of Dolci’s thought in combating educational poverty, his bequest is reinterpreted and re-actualized, in order to extrapolate his teachings that are still relevant today. The educational model proposed by Dolci represents a valuable legacy that can address the challenges posed by educational poverty with a vision that makes change not only possible, but indispensable. His perspective promotes a profound transformation of reality, which is needed now more than ever.
Marco Grifo
Il centenario della nascita di Danilo Dolci rappresenta un’importante occasione per riflettere su quanto sia stato scritto finora sulla sua figura. Sebbene la bibliografia a lui dedicata sia ampia, solo di recente la storiografia ha iniziato a trattare Dolci in modo più approfondito e critico, abbandonando gradualmente i toni agiografici che per lungo tempo avevano caratterizzato il dibattito su di lui. Questo saggio si propone di ripercorrere le principali tappe che hanno segnato l’evoluzione del discorso su Dolci. A partire dagli anni Novanta, complice un rinnovamento delle metodologie e delle categorie analitiche in ambito storico, il dibattito su Dolci si è allontanato dalla narrazione celebrativa per assumere una prospettiva più critica e scientifica. Il saggio indaga come gli storici abbiano interpretato la figura di Dolci, le categorie concettuali che hanno utilizzato e in che modo questi studi abbiano contribuito ad arricchire il panorama storiografico sull’Italia contemporanea, offrendo una comprensione più sfaccettata e complessa del suo impatto sociale e politico.
The centenary of Danilo Dolci’s birth offers a valuable opportunity to reflect on the body of work written about him thus far. While the bibliography dedicated to him is extensive, only recently has historiography begun to examine Dolci in a more in-depth and critical manner, gradually moving away from the hagiographic tones that had long characterized the discourse surrounding him. This essay aims to trace the key stages in the evolution of the discussion on Dolci. Starting in the 1990s, with the renewal of methodologies and analytical frameworks in historical studies, the debate on Dolci shifted from a celebratory narrative to a more critical and scientific approach. The essay explores how historians have interpreted Dolci’s figure, the conceptual categories they have employed, and how these studies have contributed to enriching the historiographical landscape of contemporary Italy. In doing so, it offers a more nuanced and complex understanding of Dolci’s social and political impact.
Giulia Natella, Lisa Stillo
Quali eredità oggi r(i)esistono rispetto alle lotte, le pratiche e i metodi pedagogici e politici dell’educazione popolare di cui Danilo Dolci è stato uno degli interpreti più interessanti di un vicino passato? Questa la domanda che anima le riflessioni del presente contributo, in cui si cercherà di contestualizzare e attualizzare le riflessioni e le pratiche attivate da Danilo Dolci provando a superare quel processo di idealizzazione del singolo intellettuale e militante per sottolineare il processo comunitario che all’epoca, ma in particolare oggi, assume un ruolo centrale nelle trasformazioni sociali ed educative. A tal proposito vengono presentate due attuali esperienze di educazione popolare, il Doposcuola popolare di Partinico e la Scuola Popolare Dòpolis di Ciampino, che in parte recuperano l’eredità Dolciana, ma dall’altra sembrano essere espressione di prospettive nuove e inedite attraverso cui ripensare i processi stessi dell’educazione popolare e della militanza politica. Queste esperienze si inseriscono a pieno nella lettura necessariamente complessa della realtà circostante, che obbliga la riflessione pedagogica e l’azione educativa a dotarsi di nuove lenti interpretative e di analisi. In questo senso si fa riferimento in modo particolare alla prospettiva intersezionale, alla pedagogia decoloniale e alle pratiche femministe come nuovi possibili orizzonti di senso e di posizionamento in termini pedagogico-critici.
What legacies exist today with respect to Danilo Dolci’s struggles, practices and pedagogical and political methods of popular education? The reflections in this contribution start from this question, with the aim of contextualising and actualising the concepts and practices activated by Danilo Dolci. We will try to overcome the idealisation of intellectuals as the only protagonists of social change, emphasising, instead, the community process that at the time, but especially today, plays a central role in social and educational transformations. In this regard, two current popular education experiences are presented: the Doposcuola popolare in Partinico and the Scuola Popolare Dòpolis in Ciampino. On the one hand they partially recover Dolci’s legacy, but on the other they seem to be the expression of new and unprecedented perspectives through which to rethink the processes of popular education and political militancy. These experiences fully fit into the necessarily complex reading of reality, which obliges pedagogical reflection and educational action to equip themselves with new analytical and interpretative lenses. In this sense, particular reference is made to the intersectional perspective, decolonial pedagogy and feminist practices as possible new horizons of meaning and positioning in pedagogical-critical terms.
Anselmo Roberto Paolone
Il XXIX Congresso della Comparative Education Society in Europe (CESE), tenutosi presso la Aristotle University of Thessaloniki dal 7 all’11 luglio 2024, ha approfondito il tema ‘Changing Regimes of Control in Education: Comparative Perspectives Across Time and Space’. Dal punto di vista tematico, l’evento ha evidenziato le nuove dinamiche di potere e influenza nell’educazione, collegate a processi globali, digitalizzazione, e sfide come l’inclusività e la sostenibilità. Le sessioni plenarie hanno esplorato temi chiave, come il ruolo crescente della quantificazione nelle politiche educative (Sotiria Grek), i meccanismi globali di diffusione delle politiche (Antoni Verger), l’attivismo giovanile (MiriYemini), e le relazioni di potere in campo educativo, nella prospettiva delle dinamiche legate allo spazio (Jason Beech). In particolare, il gruppo di lavoro dedicato agli young scholars è stato moderato da Stephen Carney e Anselmo R. Paolone, che hanno incentivato un dibattito costruttivo per evidenziare connessioni tra i contributi presentati. In questo senso, i contenuti del gruppo possono essere riassunti radunando i contributi in sei aree tematiche principali: politiche educative; tecnologia ed equità; inclusione e integrazione; prospettive degli studenti; dimensioni transnazionali e interculturali; coinvolgimento giovanile nei processi politici. Tuttavia, sono emerse critiche sul limitato uso di approcci di ricerca innovativi e sull’insufficiente attenzione generale alle tecnologie digitali (tendenzialmente trattate come argomento specifico da alcuni, e non come ineludibile sfondo generale di ogni riflessione sulla contemporaneità), tematiche centrali nel contesto contemporaneo.
The XXIX Congress of the Comparative Education Society in Europe (CESE), held at the Aristotle University of Thessaloniki from 7 to 11 July 2024, explored the theme of ‘Changing Regimes of Control in Education: Comparative Perspectives Across Time and Space’. The event highlighted the new dynamics of power and influence in education, linked to global processes, digitalisation, and challenges such as inclusiveness and sustainability. Plenary sessions explored key themes, such as the growing role of quantification in education policies (Sotiria Grek), global mechanisms of policy diffusion (Antoni Verger), youth activism (Miri Yemini), and power relations in education, in terms of spatial dynamics (Jason Beech). The Young Scholars working group was chaired by Stephen Carney and Anselmo R. Paolone, who encouraged a constructive debate to highlight connections between the papers presented. The group’s contents can be summarized by gathering the contributions in six main thematic areas: educational policies; technology and equity; inclusion and integration; students’ perspectives; transnational and intercultural dimensions; youth involvement in political processes. However, criticisms have emerged on the limited use of innovative research approaches and on the insufficient general attentionto digital technologies (tendentially treated as a specific topic by some, and not as an unavoidable general background of any research on contemporaneity), central themes in the contemporary context.
Cristel Schachter
L’articolo esplora l’educazione maieutica e intergenerazionale di Danilo Dolci, sottolineando la sua rilevanza per l’emancipazione umana e lo sviluppo comunitario, a sostegno di un invecchiamento attivo. Si evidenzia come l’approccio maieutico reciproco e l’apprendimento intergenerazionale, possano favorire la condivisione di conoscenze, rafforzare i legami sociali e contrastare le persistenti forme di isolamento ed esclusione sociale che caratterizzano il nostro tempo. Ciò attraverso il dialogo, l’ascolto, la partecipazione attiva, il pensiero critico-riflessivo e la responsabilità individuale e collettiva. Il tema dell’invecchiamento attivo è qui affrontato in termini di prevenzione, di formazione continua, di preparazione e di cura per e alle transizioni di vita, in risposta alle sfide demografiche, sociali e culturali contemporanee, con l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e collettivo. L’approccio educativo di Danilo Dolci, con le sue caratteristiche di reciprocità e intergenerazionalità, è, dunque, di grande attualità e rilevanza, sia per valorizzare le risorse, i saperi e le competenze individuali, sia per lo sviluppo di comunità più consapevoli, inclusive e solidali.
The article explores Danilo Dolci’s maieutical and intergenerational education, emphasising its relevance for human emancipation and community development, supporting active ageing. It highlights how reciprocal maieutical approach and intergenerational learning can foster knowledge sharing between generations, strengthen social ties and counteract the persistent forms of isolation and social exclusion that characterise our time. This is done through dialogue, the exercise of listening, active participation, critical-reflective thinking and individual and collective responsibility. The theme of active ageing is addressed here in terms of prevention, lifelong learning, preparation and care for life transitions, in order to meet contemporary demographic, social and cultural challenges and improve individual and collective well-being. Danilo Dolci’s educational approach, with its reciprocity and intergenerationality, is therefore highly topical and relevant both for enhancing individual resources, knowledge and skills and for developing more aware, inclusive and supportive communities.
Vincenzo Schirripa
Il saggio ripercorre le prime tappe dell’autocostruzione di Danilo Dolci come personaggio pubblico. Assume il processo di Palermo per lo sciopero alla rovescia del 1956 come punto di svolta che rende noto il lavoro politico dell’intellettuale nonviolento a un uditorio più ampio. Prende in considerazione la matrice religiosa della vocazione di Dolci, distinguendone le caratteristiche rispetto ad altre forme di radicalismo cattolico e mettendo in primo piano come precedente più rilevante la partecipazione alla comunità di Nomadelfia fondata da don Zeno Saltini. Passa infine in rassegna le tappe di un avvicinamento a un segmento ben preciso dell’opinione pubblica laica di sinistra, che ne favorisce la contestualizzazione in una nuova stagione del meridionalismo pedagogico attivo. Ipotizza che le implicazioni culturali e operative dell’approccio nonviolento, insieme a uno stile di leadership riluttante al consolidamento organizzativo delle sue iniziative, abbiano ammortizzato lo scarto fra premesse culturali, domanda di innovazione politica e potenzialità di attivazione dei suoi diversi interlocutori.
The essay examines the early stages of Danilo Dolci’s self-construction as a public figure. It identifies the Palermo trial for the 1956 ‘reverse strike’ as a pivotal moment that made the work of the nonviolent intellectual accessible to a wider audience. The analysis explores the religious foundation of Dolci’s vocation, distinguishing its traits from other forms of Catholic radicalism, and underscores as a key precedent his involvement in the Nomadelfia community founded by don Zeno Saltini. It then outlines the steps leading to Dolci’s engagement with a specific segment of progressive lay public opinion, facilitating his framing into a new phase of active pedagogical meridionalism. Lastly, it suggests that the cultural and practical implications of Dolci’s nonviolent approach, along with a leadership style resistant to organizational consolidation, softened the gap between implicit cultural assumptions, the demand for political innovation, and the activation potential of his various interlocutors.
Paolo Vittoria
L’architetto appassionato per la storia dell’arte non viaggia più tra le bellezze dell’antichità, ma ha il coraggio di navigare tra i dolori e la desolazione della vita reale. Quel viaggio che si ferma in Sicilia, dalla Sicilia riparte per non fermarsi più; ha il coraggio di cambiare strada per dedicarsi all’educazione, aprendo nuovi orizzonti, interrogandosi sull’abitare luoghi trascurati, abbandonati. La scelta del giovane Danilo, che nasce come rottura con una parte della propria formazione e vita, si farà poi rottura con un sistema sociale. Nel 1956 i suoi interessi di inchiesta approdano a Palermo. ‘Inchiesta a Palermo’ ci riporta un ritratto autentico, crudo del capoluogo siciliano espressione, nelle profonde e laceranti contraddizioni, di un sistema laddove analfabetismo e disoccupazione sono elementi che si integrano e compongono la base dello «Stato invisibile nello Stato».
The architect interested on the history of art no longer travels among the beauties of antiquity but has the courage to navigate among the pain and desolation of real life. That journey that stops in Sicily, from Sicily restarts to never stop and has the courage to change the way to dedicate itself to education, opening new horizons, questioning the inhabitation of neglected, abandoned places. The choice of the young Danilo, which begins as a break with a part of his education and life, will then become a break with a social system. In 1956 his inquiry interests landed in Palermo. ‘Inchiesta a Palermo’ brings us an authentic, raw portrait of the Sicilian capital, an expression, in the deep and lacerating contradictions, of a system where illiteracy and unemployment are elements that integrate and form the basis of the «invisible State within the State».
Hanno collaborato a questo numero de «I Problemi della Pedagogia»:
C. BENELLI, D. BOCCHIERI, F. BORRUSO, D. BURASCHI, C. CAPPA, S. CERASARO, C. CORSINI, G. CRESCENZA, A. CUNTI, G. D’APRILE, M.A. D’ARCANGELI, N.E. DI NUZZO, G. FRANCHI, F. GABRIELLI, M. GRIFO, T. IANNONE, G. NATELLA, M. OCCHIPINTI, L. PALMIERI, A.R. PAOLONE, A. SANZO, C. SCHACHTER, V. SCHIRRIPA, L. STILLO, F. TOVENA, P. VITTORIA, E. ZIZIOLI